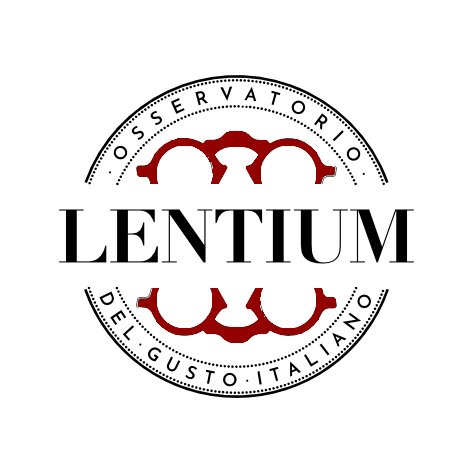Ciro è un buon figlio di famiglia.
Viene da gente d’imbarco di Torre del Greco; dove per campare ti conviene avere un amico ‘buóno’ e uno ‘càttivo’. Un posto da più di centomila abitanti, divisi tra gente di terra e gente di mare. Non pescatori. Marittimi che girano il mondo per sfamare quella famiglia che lasciano a casa per mesi, per anni.
Ma tornano sempre, se il mare glie lo permette.
Ci sono quelli, come suo padre che hanno fatto i cuochi a bordo e raccontano di caldi africani dove i boccaporti delle cucine – obbligatoriamente elettriche – non riescono a fare in tempo a buttar fuori il caldo dentro, che entra quello fuori.
Poi c’è il mare vivo ,che non voglio immaginare perché mi viene la nausea solo a pensarci; lì bisogna fare numeri da circo tra pentole e sughi, anche loro sull’agitato andante. Cuoco il padre dal magro aspetto da ragioniere di banca vecchio stile; cuochi i due figli.
Il più vecchio, sempre più giovane di me, con un fisico da vichingo, occhi azzurri e pelo che tira al rosso, sul metro e ottanta o quasi. Silenzioso e buon padre di famiglia ma…meglio lasciarlo stare.
Con lui intorno non c’è bisogno di buttafuori.
L’altro, Carmine, buon ragazzo, un po’ smanicato, è il birichino di famiglia. Tutto diverso dal resto. Un orsetto scuro con capelli così fitti da far invidia a una parrucca. Centotrenta chili per dieci centimetri in meno del fratello.
È più giovane. Come l’altro nato in cucina e per la cucina. Non si danno arie. Grazie al Cielo non sanno cosa sono e quanto sono importanti.
Possono mettere a tavola da soli un numero indefinito di persone, divertendole. Sanno tutto e hanno fatto tutto. Da spargere la segatura sul sangue di uno sparato in pizzeria giù ai Quartieri, a comandare una brigata di cuochi in un club dalle conchiglie al collo.
Una cosa li accomuna, hanno fatto la gavetta fin da piccoli. Sbagliano qualche verbo. Ma mai nulla in cucina.
Tu li guardi. Credi di conoscerli. Ma quando raccontano – in due parole argomentate a caso – sono illuminanti e pieni dell’esperienza trentennale di gente di quarant’anni.
I conti tornano, questi qui a dodici anni già ‘faticavano’: “La commare del ristorante sotto il Vesuvio aveva sentito che si lamentavano che il formaggio nella pasta era poco.
Allora veniva in cucina e ci faceva mettere nu poco e parmiggiano sul bordo del piatto. E vuoi sapere? Beh. Qualcuno lo mandava indietro per troppo formaggio. Allora lei ce lo faceva spazzare arrento a formaggiera e tutti stavano contenti.”
Noi abituati ai soliti benedetti tortelloni fatti in casa dalla solita ragazza di campagna che a novant’anni guida ancora l’auto, siamo dei semplici, basta aspettare vengano a galla. Poi li affoghi nel burro e li asciughi nel parmigiano di ventiquattro mesi ed è fatta.
Fin qui! Lo faceva anche mia madre.
Tutto dire. Con la spinta che aveva…
Ma il giorno che vuoi stupire gli ospiti e dici, senza convinzione, a uno dei due ragazzi: “Conosci il fegato grasso?”
Il più piccolo, insomma, quello grosso, senza fare una piega: “Vuoi i tournedos alla Rossini? Me lo devi dire il giorno prima che vado da un macellaio che lavora per l’Accademia Militare, un terrone anche lui, ma voialtri emiliani che puzzate di porco fresco non sapete cos’è il vero manzo da filetto rotondo!” “Rotondo?”
“Mannaggia ü bubbà, chìllo snervato tutto intorno che fa diventare burro quello che tieni in bocca.”
Rimango muto! Lui mi guarda godendo della sorpresa. Loro non ti dicono cosa sanno fare. Devi chiedere e saper chiedere.
“Tu portami il fegato d’oca, basta quello intero congelato, la marca non importa tanto nessuno conosce la differenza. E poi vengono tutti dall’Ungheria. Uhhh! Madonna.
Non tengono tutte le balle che teniamo qui. Per il tartufo usiamo il nero pregiato della nostra tartufaia.”
“Ma ne abbiamo di tuber melanosporum pico?
Che non vuole essere un esplosione di cultura; Lo dico sempre, conversando sulle abitudini della nostra tartufaia che in fondo ha ormai trent’anni e da quando abbiamo subito l’alluvione è diventata una miniera a cielo aperto. Insisto col latino perché mi infastidisce che pensino abbiamo quello povero estivo, lo scorzone, che non vale niente.
Mi guarda con sufficienza: “C’è! C’è. Tranquillo. Tu non guardi la tua roba, ma io si. Poi ti lamenti che rubo. Vengono di notte a bucare e io vengo a bucare loro.
Devi vedere come diventano gentili quando salto fori da la siepe col cappuccio, nero come la maschera del Covid!”
Non mi faccio domande su come si comportano i collaboratori fuori orario. L’importante non gli venga l’idea di chiedere anche gli straordinari; ma non penso faccia parte del minimo sindacale prendere a bastonate un tartufaio.
“Il fegato è sul chilo. Puoi invitare dieci…dodici persone. Ci vorrebbe del Madera ma noi usiamo uno stravecchio di Marsala, l’abbiamo in casa. Ma gli amici tuoi lo meritano?”
“No. Ma fatti i fatti tui. Bastardaccio napoletano. Mannaggia ü bubbà!
“Cucina Seria” di Pier Luigi Peri