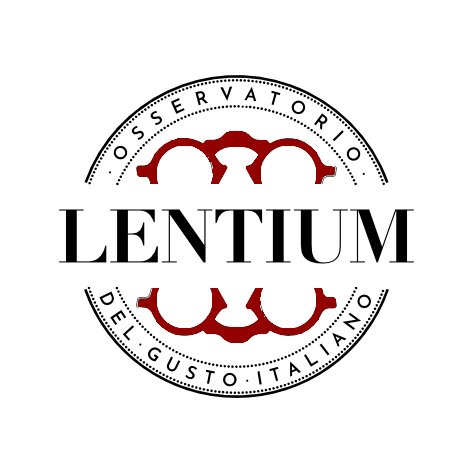Suppongo sia una cosa che accade più o meno a tutti, comunque sia a me capita sovente di arrovellarmi su una domanda che mi nasce nella mente da una sollecitazione apparentemente estranea e di non potermene liberare finché non trovo adeguata risposta.
Un giorno, per esempio, dopo aver visto la sera prima per la probabile ventesima volta “Fort Apache” (ebbene sì, sono un westerner fordiano di ferro), al risveglio ero assillato da questo dilemma: mentre Cavallo Pazzo e Toro Seduto calpestavano eroicamente coi loro ponies le spoglie di quel fesso di George Armstrong Custer a Little Bighorn, cosa accadeva, chi c’era, dalle parti di casa nostra?
Domanda epocale!
Solo dopo aver stabilito che in quegli anni la giovane Terza Repubblica parigina vedeva i primi bagliori della Belle Époque, l’esplosione dell’Impressionismo e i versi di Baudelaire, la Gran Bretagna era in piena età Vittoriana, Tolstoj scriveva Guerra e Pace, Garibaldi stava già a Caprera e Vittorio Emanuele II era tutto indaffarato coi governi Minghetti e De Pretis a consolidare l’adolescente Unità d’Italia ho potuto dedicarmi tranquillamente alla mia quotidianità.


Qualcosa di simile mi è accaduto poco tempo fa quando, invitato dagli amici parmigiani Ennio Barbieri e Andrea Pacciani dell’Atelier delle Meraviglie, ho potuto godere di una serata piacevolmente conviviale con diverse persone a vario titolo significative nell’ambito della cultura gastronomica (non esiste ambito migliore per creare un clima gaudente anche fra persone che si incontrano la prima volta e a ben disporle inoltre a farsi riprendere dall’onnipresente smartphone dell’estroso Ennio) in occasione della presentazione di un particolarissimo Piatto Ducale pensato in ceramica di forma scudale a quattro scomparti per esaltare la migliore degustazione del tortello d’erbette parmigiano.
Per diversi giorni il mio tormentone mentale è stato questo: un contenitore così originale e inconsueto sarebbe piaciuto all’autore del Manifesto della Cucina Futurista (sì, proprio lui, Filippo Tommaso Marinetti) magari per usarlo nel breve periodo nel quale aprì un ristorante con lo chef francese Jules “Joffre” Maincave?
Ho impiegato un po’ di tempo, devo ammetterlo, la domanda forse non sembra invece era complessa, ma alla fine credo che la risposta possa essere sì.

L’idea dinamica del tortello che volteggia fra i quattro scomparti del piatto per tuffarsi ad affogare nel burro fuso per poi svolazzare ad asciugarsi nel Parmigiano Reggiano prima di finire ad eccitare le nostre papille gustative riconduce al mito del movimento del volo come principio fondamentale, conditio sine qua non dell’ideologia futurista, e il fatto che ciò dimostri quanto sia fuorviante il concetto che la tradizione sia una idea incatenata al passato, immobile e immobilista, avrebbe fatto godere il buon Filippo che avrebbe potuto ampiamente disquisire su come il vero rispetto per la tradizione sia tutt’altro che una conservazione pedissequa di ciò che fu, ma al contrario una sua dinamica rivisitazione, adeguata al presente e inevitabilmente proiettata al futuro.

È vero altresì che, benché nel suddetto Manifesto auspicasse l’eliminazione della pastasciutta e l’abolizione della forchetta e del coltello, il nume futurista venne colto un bel dì in un ristorante milanese arditamente alle prese con un’avvoltolata forchettata di spaghetti fumanti e l’irriverente ironia di Petrolini non gliela fece passare liscia: “Marinetti dice Basta! / Messa al bando sia la pasta / Poi si scopre Marinetti / che divora gli spaghetti!”.

Non ci è dato sapere cosa pensasse l’avanguardista alessandrino nello specifico del tortello d’erbetta ma sono certo che avrebbe partecipato con piacere e col suo dissacrante spirito provocatorio alla discussione elaborata a tavola quella sera, dapprima attorno al racconto di Pacciani sull’origine rituale della nascita di questa pasta ripiena, avvalorata da una pala d’altare rinascimentale del Battistero di Parma (opera di Filippo Mazzola, padre del meritatamente più noto Parmigianino), che ammanterebbe di spiritualità l’atavica consuetudine/necessità di cogliere le verdure al tempo della rugiada di San Giovanni, quindi alimentata dalla pragmatica teoria di Andrea Grignaffini sul riutilizzo popolare di una ricotta altrimenti di scarsa qualità, infine qua e là insaporita dalle facezie argute del conte Pier Luigi Peri e dai racconti della sua avventura di vita.
Se i saporosi tortelli forniti da Silvano Romani e prima di questi il magnifico e grasso prosciutto di Francesco Piazza (rigorosamente tagliato a coltello) hanno potuto allietare pienamente i raffinati palati degli astanti lo si deve innanzitutto alla straordinaria figura dello chef albino (no, pardon)… albigese (no, nemmeno)… aahh, ecco, albese (insomma, venuto fin dalla piemontese cittadina di Alba apposta per noi dal suo ristorante Dulcis Vitis) Bruno Cingolani e alla sua non comune capacità di nobilitare la figura dell’oste, per la quale non basta essere maestri in cucina, occorre soprattutto avere idee chiare, proprie, e saperle trasmettere con arte da intrattenitore agli ospiti che ogni volta, dopo avere parlato con lui, possono ben dire di aver sempre imparato qualcosa. Figura questa di Bruno che definirei, si parva licet componere magni, michelangiolesca.

Così come il Buonarroti sosteneva che la figura da scolpire è già presente all’interno del blocco di marmo e all’artista compete solo di eliminare il superfluo, così Cingolani difende l’idea che il valore di un piatto (inteso come cibo) è intrinseco nella selezione di qualità dei suoi ingredienti e al cuoco compete doverosamente di togliere ogni ridondante orpello inutile alla sua valorizzazione: il paradosso ossimorico della semplicità che alla fine si rivela in ogni arte come la qualità più difficile da raggiungere (provare per credere quella focaccia di farro Enkir che accompagnava il prosciutto).
Questo l’insegnamento che a me è rimasto dopo aver gustato al meglio un “semplice” sapore antico, grazie al “semplice” concetto moderno di questo Piatto Ducale (inteso come oggetto) e alla “semplice” chiacchiera della dotta compagnia attorno al tavolo. Come accade nei casi più fortunati, è il dolce sapore di crostate, dove protagonisti sono ancora il farro Enkir e le succulente marmellate di produzione Dulcis Vitis, ad accompagnare un tranquillo ritorno a casa, avvolto nel fumo denso del mio Toscano Antico e da quella improbabile immagine di Marinetti che lentamente comincia a invadere tormentosa le mie sinapsi.